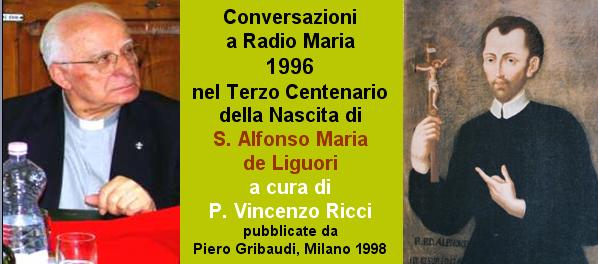
15. S. Alfonso maestro di morale: verità e libertà nella carità.
I riconoscimenti del Magistero [i titoletti sono redazionali]
Con un salto cronologico nella maturità di S. Alfonso, vorrei evidenziare il suo cammino di moralista e di pastore confrontato dalle problematiche morali del suo tempo.
Prima, però, occorre dire una parola sul perché di questo riferimento a S. Alfonso come maestro di morale, a distanza di più di duecento anni e in contesti molto diversi. La risposta, oltre che nel valore intrinseco della sua teologia morale e pastorale, sta in un dato che a noi sacerdoti deve sempre stare a cuore: è lo stesso magistero della Chiesa che ci propone S. Alfonso come punto di riferimento sicuro nel campo morale, con una serie di interventi che, attraversando tutto l’Ottocento, arrivano fino ai nostri giorni.
Accenno ad alcuni più significativi. Nel maggio del 1803, la Congregazionedei Riti, nel contesto dei passi esatti dal processo di beatificazione, termina l’esame degli scritti alfonsiani dichiarando che in essi non si trova «niente degno di censura» (1). Trent’anni più tardi la Penitenzieria Apostolica, rispondendo a quesiti posti dal cardinale Rohan‑Chabot, afferma che si possono «seguire con sicurezza» le posizioni alfonsiane (2). Pio IX, proclamandolo Dottore della Chiesa nel luglio del 1871, sottolinea che in Alfonso si trova la «via sicura» tra gli opposti scogli del rigorismo e del lassismo (3). Più vicino a noi, nell’aprile del 1950, Pio XII lo propone come Patrono dei confessori e dei moralisti, ricordando che la sua dottrina è «esimia e diffusa dovunque» (4).
Nell’agosto del 1987, commemorando il secondo centenario della morte del Santo, Giovanni Paolo II scrive: Alfonso «fu maestro di sapienza al suo tempo e con 1’esempio della vita e con l’insegnamento continua ad illuminare, come luce riflessa di Cristo, luce delle genti, il cammino del popolo di Dio… Alfonso fu rinnovatore della morale: a contatto con la gente incontrata in confessionale, specialmente nel corso della predicazione missionaria, egli gradualmente e non senza fatica sottopose a revisione la sua mentalità, raggiungendo progressivamente il giusto equilibrio tra la severità e la libertà… Non c’è dubbio che la Praxis Confessarii; Homo Apostolicus e l’opera principale, la Theologià Moralis, hanno fatto di lui il maestro della morale cattolica» (5).
Credo che questa costante proposta da parte del Magistero sia preziosa particolarmente per noi sacerdoti: è giusto rivolgerci a S. Alfonso come punto di riferimento sicuro nel ministero, complesso e impegnativo, affidatoci dalla stessa Chiesa, di aiutare i fedeli nella formazione della coscienza perché possano individuare correttamente e scegliere effettivamente il bene nella vita di tutti i giorni.
Il cammino di moralista
Alla luce di questa premessa, che dà ulteriore motivazione alla nostra riflessione, vorrei invitare tutti ad avvicinarsi al cammino di Alfonso come moralista, per coglierne i tratti fondamentali.
La formazione teologico‑morale di Alfonso risente del clima del primo Settecento napoletano, contrassegnato da tendenze rigoriste o probabilioristiche. Viene sottolineata la priorità della legge sulla libertà, sostenendo che, nei casi dubbi, l’ultima parola spetta sempre alla prima, cioè alla legge. Di conseguenza, nella pastorale dei sacramenti ‑ soprattutto della confessione e dell’eucaristia ‑ ci si ispira a una severità che finisce inevitabilmente con l’allontanare i fedeli dagli stessi sacramenti.
In questo contesto Alfonso riceve la prima formazione teologica. Egli stesso lo ricorda rispondendo nel 1764 a uno dei suoi critici: «Sappia V P. ch’io nel fare gli studi ecclesiastici ebbi per miei direttori a principio maestri tutti seguaci della rigida sentenza; ed il primo libro di morale che mi posero in mano fu il Gemetti, capo de’ probabilioristi; e per molto tempo io fui acerrimo difensore del probabiliorismo» (6).
Questo il punto di partenza di Alfonso moralista: difensore del probabiliorismo. Ma i convincimenti della prima formazione non durano a lungo. Entrano in crisi quando la predicazione missionaria agli abbandonati e le confessioni lo mettono a contatto con la vita concreta: «Ma poi, continua Alfonso, considerando le ragioni della sentenza contraria, e specialmente quella sulla quale ho fondata la mia dissertazione, cioè che la legge incerta non può indurre un’obbligazione certa, mutai sentimento» (7).
Più dettagliata è la confessione tracciata precedentemente, in una dissertazione del 1749: «In seguito, nel corso del lavoro missionario, abbiamo scoperto che la sentenza benigna è comunemente sostenuta da numerosissimi uomini di grande onestà e sapienza… ne abbiamo perciò ponderato accuratamente le ragioni e ci siamo accorti che la sentenza rigida non solo ha pochi patroni e seguaci ‑ e questi dediti forse più alle speculazioni che all’ascolto delle confessioni ‑, ma è anche poco probabile, se si vagliano i principi, e per di più circondata da ogni parte da difficoltà, angustie e pericoli. Al contrario abbiamo scoperto che la sentenza benigna accettata comunemente, è molto più probabile dell’opposta, anzi è probabilissima e, secondo alcuni, non senza un fondamento molto grave, moralmente certa» (8).
Nella Theologia moralis aggiunge una punta di ironia napoletana nei riguardi degli autori di ispirazione rigorista: «Come potevano convincermi vedendo che essi generalmente si sforzano di appoggiare le loro sentenze più con invettive e derisioni che con la forza delle ragioni? Come avrei potuto aderire in tutto a coloro che il più delle volte proclamano le loro opinioni come più vere e più conformi al Vangelo solo perché sono più rigide e sovente si fanno scherno di quelle contrarie, come false e opposte al Vangelo, solo perché favorevoli alla libertà?» (9).
L’ascolto dei poveri
La morale alfonsiana nasce da questa «conversione», stimolata dalla verifica pastorale. Si svilupperà mettendo sempre in fecondo rapporto la riflessione teorica e la concretezza della vita, l’annuncio franco con l’ascolto sincero dei poveri e degli abbandonati.
Collocandole su questo sfondo possiamo meglio cogliere il significato delle posizioni alfonsiane. Le ricordo con le parole della Theologia moralis: è «certo, o da ritenere come certo… che agli uomini non si devono imporre cose sotto colpa grave, a meno che non lo suggerisca una evidente ragione», cioè una legge incerta non può indurre un obbligo certo; inoltre «considerando la presente fragilità della condizione umana, non è sempre vero che sia più sicuro avviare le anime per la via più stretta, mentre vediamo chela Chiesa ha più volte condannato sia l’eccessiva libertà che l’eccessivo rigore» (10).
Se si riflette che quando Alfonso parla di fragilità, ha presente la condizione di miseria e di difficoltà dei poveri e degli abbandonati, appare chiaro che ci troviamo di fronte a una prospettiva fondamentale della morale cristiana, che si pone come condizione indispensabile della sua coerenza con il Vangelo. Si tratta perciò di istanze che chi oggi è impegnato nell’annunzio e nella formazione morale non può mai dimenticare. Del resto sappiamo bene che lo Spirito è in azione in tutto il popolo di Dio e in ogni coscienza: annunziare è sempre anche ascoltare. E ascoltando gli ultimi, i piccoli, i deboli che comprendiamo meglio la stessa verità che siamo inviati ad annunciare.
Alfonso sottolinea anche un’altra urgenza, più fondamentale ancora: non dobbiamo mai allontanarci dalla maniera con la quale Cristo ha incontrato chi è segnato dalla dura esperienza del peccato. Occorre farci eco fedele del suo «Neanche io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più» (Gv 8,11). Possiamo efficacemente stimolare al superamento del peccato e al cammino generoso sulla strada del bene, solo se lo facciamo con un senso di misericordia: come il Cristo ha fatto e fa con noi.
È frutto di questo cammino, in condivisione e in ascolto degli abbandonati alla luce della «condotta» misericordiosa del Cristo, la proposta alfonsiana articolata intorno alla benignità pastorale, chela Chiesaci addita come la «via media» capace di farci evitare gli estremismi opposti del lassismo e del rigorismo.
Una morale messa continuamente a confronto
Anche dopo aver maturato le linee fondamentali di tale visione, Alfonso non si ferma nella ricerca della verità. Fino agli ultimi anni della sua lunga vita continua a studiare, ricercare, confrontarsi.
È questo l’altro aspetto della biografia teologico‑morale di Alfonso che mi preme sottolineare. Viene da lui stesso sintetizzata nel 1756 nella Risposta ad un suo critico anonimo: «Nelle questioni più dubbie non ho sparambiata [risparmiata] fatica in osservare gli autori così moderni come antichi, così della benigna come della rigida sentenza… Specialmente poi mi sono affaticato ad osservare in fonte tutti i testi canonici che s’appartenevano alle materie trattate. Quando ho ritrovato qualche passo di santo Padre spettante alle cose controverse, ho procurato di notarlo colle proprie parole, con farvi tutta la riflessione e darvi tutto quel peso che meritavasi la sua autorità. Inoltre sono stato attento a trascrivere ed avvalermi delle dottrine di S. Tommaso, cercando di osservarle tutte nelle proprie fonti. Di più nelle controversie più intrigate, non avendo potuto risolvere i miei dubbi colla lettura degli autori, ho procurato di consigliarmi con diversi uomini dotti» (11).
Questa ricerca costante, fatta di confronto e di dialogo, che non permette di fermarsi nel cammino verso la verità, è a noi oggi ancora più necessaria, essendo chiamati ad annunziare la verità incarnandola in un mondo in costante e accelerata evoluzione. Tutto però deve essere fatto con una lealtà incondizionata verso la verità: «Nella scelta delle opinioni, continua Alfonso, ho cercato sempre di preferire la ragione all’autorità; e prima di dare il mio giudizio ho procurato di mettermi in una totale indifferenza e di spogliarmi da ogni passione che mi avesse potuto trasportare a difendere qualche opinione non abbastanza soda» (12).
Può perciò respingere lo «scrupolo» che gli avversari tentano di inoculargli: « In quanto poi allo scrupolo che vuole impormi il mio venerato censore per le cose che ho scritte, gli dico ch’io ben temo del conto che ho da dare a Dio della mia malavita menata nel secolo (a Gesù principalmente e poi a Maria, madre e avvocata mia appresso Gesù Cristo, stanno le mie speranze del perdono), ma in quanto poi alle dottrine che ho registrate nella mia opera non ho fondamento di temere di doverne dar conto a Dio» (13).
Con lo sguardo fisso su Cristo e sui poveri
Questo amore per la verità e questa chiarezza di coscienza lo vaccinano dalla tentazione di cedere alle mode del momento e non lo fanno esitare, come emerge dalle varie edizioni della Theologia moralis, a modificare delle affermazioni, quando lo ritiene necessario per il bene delle anime. Può perciò scrivere nel gennaio del 1762 al suo editore, G. B. Remondini: « La morale è un caos che non finisce mai. lo all’incontro sempre leggo, e sempre trovo cose nuove. Certe cose le passo, ma certe cose più importanti di nuovo le noto» (14). Più forte di qualsiasi altra cosa è, in Alfonso, la lealtà verso la verità, che vuol servire con quello spirito di misericordia, che la rende sperimentabile anche ai piccoli.
Da vescovo, ai sacerdoti della sua diocesi di Sant’Agata dei Goti, non si stanca di ripetere: « Il confessore per ben esercitare il suo officio, non deve lasciare lo studio della Morale. Questa scienza non è così facile, come alcuni la credono: ella è molto difficile, ed è molto vasta per ragione delle innumerabili circostanze che possono occorrere in ogni caso di coscienza, e perciò collo studiare sempre s’imparano cose nuove» (15).
Alfonso moralista è questo ricercatore instancabile e appassionato della verità con lo sguardo fisso sul Cristo e sui poveri. Cerca perciò di enuclearla e di proporla in maniera che arrivi salvificamente nella vita concreta di ogni persona. La verità morale non è una verità che arriva sull’uomo per schiacciarlo e rinchiuderlo nella sua situazione di peccatore; è sempre una verità che, come il Cristo, entra nella miseria, nella malattia, nella schiavitù, ma per arricchire, guarire, liberare: è verità che apre al bene e mette in cammino verso la santità.
Per Alfonso essa deve essere sempre illuminata da un convincimento fondamentale, così sintetizzato nella Pratica di amar Gesù Cristo: « È un grande errore quel che dicono alcuni: Dio non vuol tutti santi. No, dice S. Paolo, “Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione” (1Ts 4,3). Iddio vuol tutti santi, ed ognuno nello stato suo, il religioso da religioso, il secolare da secolare, il sacerdote da sacerdote, il maritato da maritato, il mercadante da mercadante, il soldato da soldato, e così parlando di ogni altro stato» (16).
Partendo dalla fragilità e dalla debolezza, in cui siamo stati immersi dalla storia dominata dal potere del peccato, l’annuncio morale deve far sperimentare la possibilità nuova aperta dal dono dello Spirito da parte del Cristo, mettendo in tensione leale verso la stessa perfezione misericordiosa del Padre. Sta qui il cuore della proposta morale di S. Alfonso; di qui scaturiscono le sue prospettive fondamentali. Si tratta di intuizioni e di istanze pienamente evangeliche, che conservano la loro carica ispirativa anche per noi oggi.
Dialogo col conduttore Don Tino
- – Don Tino: Abbiamo avuto l’impressione di vedere S. Giovanni che posa il capo sul petto di Cristo per sentire i suoi battiti d’amore. S. Alfonso penso che abbia veramente riposato sul cuore di Cristo e con quel suo amore veramente formidabile per Cristo Crocifisso, Cristo Eucaristia, che sono stati la ragion d’essere della sua vita. Il cuore di Cristo in quanto un cuore che perdona, che ci accoglie, che ci comprende: in questo senso.
- – Padre Majorano: Ricordava S. Alfonso che sia nel fare morale che nel fare pastorale noi non dobbiamo mai discostarci dalla condotta del Redentore. E la condotta del Redentore è proprio il cuore di Dio che si avvicina al cuore di ogni uomo per mettere in movimento, per aprire, per dire che anche se fino a quel momento siamo stati prigionieri del peccato siamo ormai liberi, possiamo intraprendere un cammino di dignità, un cammino di santità. Ecco questa è la morale alfonsiana.
- – Don Tino: E siccome stai parlando in modo prevalente ai sacerdoti mi sembra che questo dovrebbe essere ciò che devono trovare le anime quando vengono a confessarsi. No?
- – Padre Majorano: Parlando degli uffici del confessore S. Alfonso diceva che il primo ufficio del confessore è di essere padre, cioè di far sperimentare, a chi viene a confessarsi che c’è un cuore di padre che lo aspetta, che lo accoglie, che gli dice che può diventare nuovo, può camminare. E il primo compito del confessore secondo S. Alfonso.
- – Don Tino: In questo caso la confessione diventa proprio una medicina, anche ridando l’entusiasmo.
- – Padre Majorano: Sì, don Tino la parola medicina che ha usato è proprio la parola giusta. E dovremo come sacerdoti ricordare che la verità morale è sempre una medicina. Una medicina che bisogna far entrare in maniera valida nella vita di chiunque incontriamo sia nel confessionale, sia nella pastorale. Ma quando la verità che annunziamo non arriva come medicina, allora perde qualcosa della autenticità evangelica.
- – Don Tino: Penso che quanto ci hai detto sia motivo di verifica per noi sacerdoti che pratichiamo spesso anche quotidianamente il confessionale. E chiede una preghiera.
- – Padre Majorano: Penso che la morale la si impari più in ginocchio che sui libri in ultima analisi, in ginocchio pregando e in contatto con la gente povera e non tanto sui libri.
- Don Tino: È pure molto notevole quello che hai detto nel Il punto che S. Alfonso continuamente si aggiornava, e confrontava la sua dottrina morale con gli Autori.
- – Padre Majorano: Anche dai suoi sacerdoti esigeva tantissimo quando era vescovo. Con noi Redentoristi insisteva ancora di più sull’obbligo che come sacerdoti abbiamo per uno studio continuo, però uno studio non solo cerebrale, ma fatto di preghiera, di ascolto, di verifica costante nella pastorale.
- – Don Tino: Adesso ti chiedo di dare a noi sacerdoti che ti ascoltiamo una benedizione particolare a nome di S. Alfonso.
- – Padre Majorano: Prego che lui ci benedica tutti, e ci dia quella sua lealtà verso la verità e verso la coscienza nel giudizio personale perché possiamo per tutti continuare oggi la condotta misericordiosa del Redentore.
da Roma 11 gennaio 1996
P. Sabatino Majorano

___________
Note
(1) Acta Doctoratus, Roma 1870, p. 80.
(2) Ivi, p. 91.
(3) Lettera apostolica Qui Ecclesiae, in S. ALFONSO, Theologia moralis, ed. GAUDÉ, I, Roma 1905, p. XLIX.
(4) Lettera apostolica Consueverunt omni tempore, in AAS 42 (1950) p. 596.
(5) Spiritus Domini, in AAS 79 (1987) p. 1365 e 1367.
(6) Apologie e confutazioni, 1, Monza 1831, p. 111 112. Il testo a cui fa riferimento è la Theologia moralis seu resolutio casuum conscientiae juxta Sacrae Scripturae, Canonum et Sanctorum Patrum mentem dell’avignonese E GENET (1640 1703) edito a Grenoble nel 1676.
(7) Apologie e confutazioni…, p. 112.
(8) Dissertatio scholastico-moralis pro usu moderato opinionis prababilis in concursu probabilioris, in Dissertationes quatuor, Monza 1832, p. 77 78.
(9) Lib. III, tract. V, cap. II, dub. I, n. 547, ed. Gaudé, II, Roma 1907, p. 53.
(10) Ivi.
(11) Apologie e confutazioni…, p. 77.
(12) Ivi, p. 77 78.
(13) Ivi, p. 76 77.
(14) Lettere, III, Roma 1890, p.144 145.
(15) Ivi, p. 591 592.
(16) Cap. VIII, n. 10, in Opere ascetiche, I, Roma 1933, p. 79.