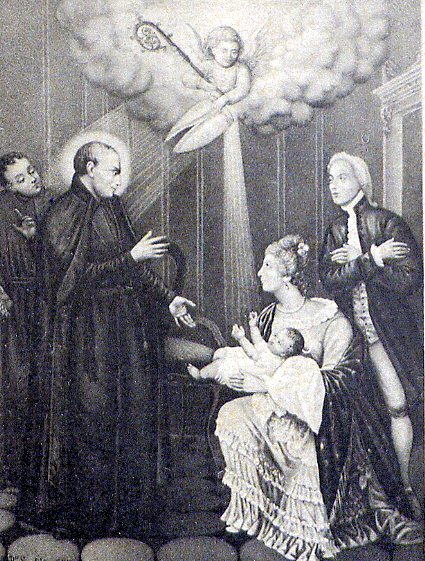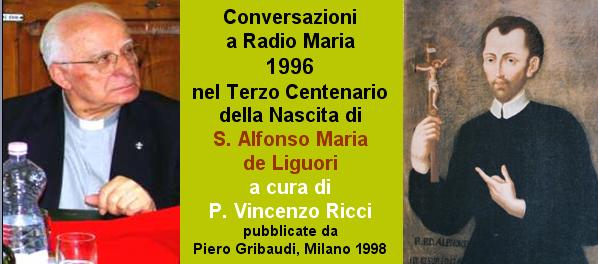2. Il papà di S. Alfonso: Giuseppe de Liguori
Un papà dal forte influsso
Nella spiritualità di S. Alfonso la Passioneha un posto molto rilevante: nelle opere che ha scritto, come pittore, nel suo celebre Crocifisso, eccellente per fattura e come musicista in questo Duetto, nelle canzoncine.
Come mai S. Alfonso ha scoperto la sua vocazione musicale ed ha avuto questa partecipazione così profonda alla Passione del Signore? Una devozione così caratteristica in lui che ha inciso profondamente anche nella sua dedizione alla vita cristiana? Questo lo deve a suo padre.
Abbiamo già parlato dell’influsso della madre, del libretto di preghiere che lui conservò e recitò tutta la vita, della devozione alla Madonna, del rosario che dicevano ogni giorno con gli altri fratelli.
Il padre, essendo occupato nelle sue avventure marinaresche contro i corsari, non era così spesso a casa. Però anche lui ebbe un grande influsso su S. Alfonso. E partiamo dalla musica.
Certo S. Alfonso aveva un talento naturale, ma lo aveva ereditato da suo padre, anche lui appassionato di musica e soprattutto di clavicembalo che si dilettava spesso a suonare. Inoltre amava portare il figlio a teatro, lo accompagnava nella crescita musicale. Avendo scoperto nel figlio l’inclinazione alla musica che lui stesso non era riuscito a coltivare, gli faceva fare tre ore di musica al giorno, tre ore con i migliori musicisti. Padre Marcelli parlando di queste lezioni (1), ha ricordato anche che il padre quando non era presente, li chiudeva a chiave, si metteva la chiave in tasca fino al ritorno nel timore che andassero via. S. Alfonso ammetterà poi di aver impiegato troppo tempo nello studio della musica perché la conoscenza così approfondita procura più disagio che diletto: un buon musicista soffre quando sente della musica strapazzata. Perciò si rammaricava che questa sua formazione a volte lo portasse a soffrire.
Un’altra passione che il padre ha cercato di sviluppare nel figlio è la pittura. Il papà era un appassionato di pittura. Discepolo del Solimena, frequentava la bottega di questo celebre pittore napoletano, diventando un ottimo miniaturista. Vi portò anche il figlio che diventò un buon pittore, come dice Padre Marcelli (1).
L’amore alla Passione.
Il papà era un buon cristiano, frequentava i sacramenti e andava in chiesa: non era solo un lupo di mare. Faceva gli esercizi spirituali ogni anno dai Lazzaristi e dai Gesuiti: erano i luoghi dove allora facevano gli esercizi i nobili e, quando Alfonso divenne più grande lo portava con sé e vi partecipavano insieme. Poi, a mano a mano che crebbe, se lo portò anche alla vita politica, alle attività sociali. Avevano un seggio in quello che allora corrispondeva ai nostri consigli di quartiere: ne avevano in mano la direzione, la giustizia, l’amministrazione ordinaria. Il seggio era ereditario e passò poi a S. Alfonso che si impratichì anche di amministrazione pubblica.
Il papà aveva molta devozione alla Passione del Signore ‑ una devozione molto diffusa nel nostro Seicento ‑ e aveva nella sua nave quattro statuette, che ora si conservano presso noi Redentoristi nella casa di Ciorani, che raffigurano Gesù che sta agonizzando nell’orto, Gesù flagellato alla colonna, 1’Ecce Homo e Gesù che porta la croce. Queste statuette, molto colorate, tipiche della pietà del Seicento nei loro atteggiamenti di sofferenza, si trovavano nella sua cabina di comando e lui stesso raccontava che lo avevano salvato tante volte durante le sue peripezie marinaresche. Grazie alla sua forte personalità, trasmise anche al figlio questo suo amore a Gesù appassionato: Gesù che muore per noi, Gesù che ci salva, Gesù che si dona totalmente a noi.
Messi da parte questi due aspetti come tipico fondamento della pietà alfonsiana, vogliamo andare ad un altro punto. Non è che il padre si disinteressasse anche del resto dell’educazione del figlio, specialmente quando diventò più grande. Per esempio, quando cominciò gli studi superiori e poi l’università, gli impose un orario di lavoro, un orario molto duro. Aveva un’ora soltanto di ricreazione in tutto il giorno. Inoltre doveva fare musica. Aveva i giorni di ricreazione ordinaria e quelli di ricreazione straordinaria. Faceva tutti gli studi in casa.
Quando si iscrisse all’università faceva gli studi fuori. Le domeniche erano ricreazioni ordinarie, mentre le feste infrasettimanali, allora erano parecchie, i giorni di ricreazione straordinaria. Quando non c’era lezione, il padre se lo portava a caccia, come erano soliti fare i nobili. Alfonso vi andava volentieri, senza però aver mai abbattuto una preda. Oltretutto era miope e non ci sarebbe mai riuscito. Comunque la caccia gli ripugnava. L’unica cosa che lo divertiva era fare la vita all’aperto.
Una volta quest’ora di ricreazione trascorse senza che se ne accorgesse. Era solito andare in casa di un amico in un palazzo vicino per giocare a carte. Vi si era appassionato e quel giorno, una partita tira l’altra, l’ora passò. Il padre si mise a passeggiare su e giù ad attenderlo. Visto che non arrivava e tardava, che fece? Gli mise sul tavolo da studio tanti mazzi di carte sparse e quando lo vide entrare disse: ecco i tuoi libri. S. Alfonso, di fronte all’ira del padre, disse che non l’aveva fatto apposta, che si era dimenticato. Per quella volta il padre lo perdonò. Ma credo che non ce ne sia stato più bisogno perché, a parte la lezione della severità del padre, Alfonso era molto ligio al dovere.
Il padre non lo risparmiava. Era un tipo collerico, ma anche il figlio non era da meno. Una volta, quando Alfonso era già un celebre avvocato e aveva superato i venti anni, c’era una festa a casa loro e i servi dovevano accompagnare gli ospiti con le torce accese. Siccome un servo tardava, don Giuseppe spazientito si mise ad inveire contro questo poveraccio. Alfonso, anch’egli presente per fare gli onori agli ospiti, disse: «Padre, quando cominciate non la finite più». Non l’avesse mai fatto! Il padre non ci vide più e gli diede un manrovescio da farlo girare più volte su se stesso. Alfonso, buono buono, gli chiese scusa. Era già un celebre avvocato del foro di Napoli. C’era un rapporto di libertà pur nell’autorità.
Il padre se lo portava anche ai teatri e presso le famiglie dove si davano feste: Alfonso era ricercatissimo, prima di tutto perché era un buon partito e poi perché suonava divinamente. Suo padre, con gli altri genitori, cercava di combinare matrimoni. Ma Alfonso aveva già fatto in cuor suo una diversa scelta di vita per cui mandava regolarmente a monte i progetti del padre.
Ricordava Padre Marcelli che una volta, in una rappresentazione teatrale, Alfonso fece la parte del diavolo, perché il diavolo doveva suonare il clavicembalo e Alfonso che era un mago nel toccarlo ‑ ottimo musicista non solo come compositore ma anche come esecutore ‑ suonò così bene da mandare tutti in visibilio. Quando suonava il clavicembalo nelle riunioni mondane, le fanciulle cantavano e facevano a gara per andargli vicino, per mettersi in evidenza e anche per cercare di accalappiarlo. Una volta, una ragazza, mentre lui suonava, fingendo di leggere la musica gli si avvicinò con la guancia accesa; ma lui si scansò. Lei allora, dopo un po’ sbottò: «Ma che ci ha o zi paglietta ‑ come venivano chiamati gli avvocati per via del loro cappello ‑ che gli ha preso, l’artéteca?» ‑ In napoletano 1’«artéteca» significa le convulsioni.
Sono solo alcuni piccoli episodi che ho voluto raccontare per dire che nella vita di S. Alfonso, oltre all’influsso preponderante della mamma, c’è stato anche quello del padre. E poi, nelle cose umane, c’è la grazia di Dio, lo Spirito Santo che ci guida e si serve delle opere umane per plasmare a modo suo le persone.
Da qui vedremo una caratteristica di S. Alfonso che è un napoletano. Si dice sempre «dolce far nulla» quando si parla di Napoli, e che la gente del Sud ama poco lavorare e cose simili. Ma l’autore della vita di S. Alfonso che io ho tradotto dice: «L’amore al lavoro è la costante più evidente nella vita di Alfonso che fece il voto di non perdere mai tempo e fare sempre il più perfetto». Ecco qui anche la mano del padre.
da Roma 16 maggio 1996 P. Vincenzo Ricci
_________
(1) Cfr. conferenza dell’11 aprile: S Alfonso musicista.
(2) Cfr. conferenza del 29 febbraio: S. Alfonso pittore.