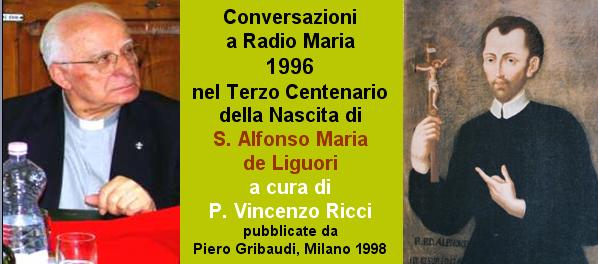
16. S. Alfonso: al servizio delle coscienze.
Al cuore del problema morale [i titoletti sono redazionali]
Dopo esserci soffermati su come S. Alfonso è diventato moralista, prendiamo in considerazione il suo insegnamento e più particolarmente cosa egli ci dice nei riguardi della ministerialità per l’autentica formazione delle coscienze, che costituisce una componente importante del nostro servizio presbiterale.
Come punto di partenza suggerisco le indicazioni fondamentali che Giovanni Paolo II traccia nei riguardi di tale ministerialità nella Veritatis splendor. Al termine della sezione II del cap. II, relativa al rapporto tra la coscienza e la verità, egli scrive: «La Chiesa si pone solo e sempre al servizio della coscienza, aiutandola a non essere portata qua e là da qualsiasi vento di dottrina secondo l’inganno degli uomini (cfr. Ef 4,14), a non sviarsi dalla verità circa il bene dell’uomo, ma, specialmente nelle questioni più difficili, a raggiungere con sicurezza la verità e rimanere in essa» (n. 64). E più tardi aggiunge: «Quest’opera della Chiesa trova il suo punto di forza ‑ il suo “segreto” formativo ‑ non tanto negli enunciati dottrinali e negli appelli pastorali alla vigilanza, quanto nel tenere lo sguardo fisso sul Signore Gesù. La Chiesa ogni giorno guarda con instancabile amore a Cristo, pienamente consapevole che solo in lui sta la risposta vera e definitiva al problema morale» (n.85).
Questi due passi della Veritatis splendor riassumono molto bene ciò che S. Alfonso ha cercato di fare nella sua vita e nelle sue opere. La ricerca e l’annuncio, cui dedica tutte le sue energie, hanno in lui il volto di un umile ministero, tendente a far sì che possa realizzarsi effettivamente l’incontro «misterioso» (in quanto opera dello Spirito) tra coscienza e verità, da cui scaturisce la responsabilità morale.
L’annuncio morale come ministero alle coscienze
Vivere come ministero alle coscienze l’annuncio morale si pone oggi per noi sacerdoti come un’urgenza pastorale tra le più fondamentali. Significativo al riguardo è quanto lo stesso Giovanni Paolo II scrive nel n. 35 della Tertio millennio adveniente: «Un altro capitolo doloroso, sul quale i figli della Chiesa non possono non tornare con animo aperto al pentimento, è costituito dall’acquiescenza manifestata, specie in alcuni secoli, a metodi di intolleranza e perfino di violenza nel servizio della verità». È certamente necessaria una lettura attenta che non dimentichi il contesto di queste realtà storiche. «Mala considerazione delle circostanze attenuanti non esonerala Chiesa dal dovere di rammaricarsi profondamente per le debolezze di tanti suoi figli, che ne hanno deturpato il volto, impedendole di riflettere pienamente l’immagine del suo Signore crocifisso, testimone insuperabile di amore paziente e di umile mitezza». Di qui la « lezione per il futuro» per ogni cristiano (e noi possiamo aggiungere: soprattutto per ogni sacerdote) «tenersi saldo nell’aureo principio dettato dal Concilio: ‘La verità non si impone che in forza della stessa verità, la quale penetra nelle menti soavemente e insieme con vigore”» (1).
S. Alfonso è testimone eloquente di tutto ciò: la sua vita è retta dalla costante preoccupazione a fondere insieme l’annunzio franco della verità e la ministerialità sincera alle coscienze nel loro cammino di apertura e di riconoscimento della stessa verità.
Il suo primo biografo, Antonio Tannoia, sintetizza così i primi passi dell’attività sacerdotale di Alfonso: «Animato dallo Spirito di Dio, non predicava Alfonso che Cristo Crocifisso. Non vi erano frasche nelle sue prediche, ed apparati vani di inutili erudizioni. Tutto era nerbo, e sostanza, con stile piano, e familiare… Non tantosto si vide sedere al Tribunale della Penitenza, che accerchiato ne venne il nuovo Confessore da una moltitudine di Penitenti. Prodigioso era il numero di qualunque ceto e condizione che da ogni parte vi concorreva… Tutti accoglieva Alfonso con una carità sopraffina; e siccome la mattina era il primo a presentarsi in Chiesa, così era l’ultimo a levarsi dal confessionale» (2).
Evangelizzazione e confessione resteranno per tutta la vita di Alfonso impegni prioritari. A contatto con la gente più umile, egli matura il convincimento della loro inscindibilità: non basta annunciare la verità, bisogna anche aiutare le persone a incarnarla nella loro vita. Di qui la raccomandazione ripetuta in mille modi fino al termine della vita: il ministero delle confessioni è «il più profittevole per le Anime, e ‘l meno soggetto a vanità per un Operario Evangelico; perché… per mezzo di questo più che per qualunque altro ministero, le Anime si riconciliano immediatamente con Dio, e loro si applica con soprabbondanza il sangue di Gesù Cristo» (3).
Nella Selva di materie predicabili ed istruttive, l’opera che sintetizza la sua visione del sacerdozio, non esita a scrivere che «l’esercizio più giovevole per salvare le anime è l’impiegarsi nel sentir le confessioni». Il motivo viene esplicitato con un’immagine colorita: «col predicare si gittano le reti, ma col confessare si tirano al lido e si pigliano i pesci» (4).
Traducendo nel nostro linguaggio, mi sembra che si debba dire: l’annuncio della verità è sempre l’inizio del cammino di fede, ma l’apertura della coscienza alla verità, la sua assimilazione, il farla diventare vita sono decisivi come lo stesso annuncio. Ne deriva che chi evangelizza deve preoccuparsi non solo della verità da proporre, ma anche di fare in modo che la coscienza si apra ad essa, la riconosca, la accolga, la decida. Tutto ciò è visto da Alfonso come essenziale all’autentica evangelizzazione ed esige un atteggiamento di sincera ministerialità nei riguardi delle coscienze.
La proposta morale alfonsiana
Sono questi i convincimenti profondi che determinano la proposta morale alfonsiana, dandole accenti e prospettive che mi sembrano particolarmente importanti ancora oggi. Innanzitutto la reciprocità tra coscienza e norma morale che Alfonso pone come base della teologia morale, fin dalla prima pagina delle sue principali opere: « La prima regola del bene operare è la legge divina, alla quale poi dee uniformarsi la coscienza; ma perché la bontà o malizia delle azioni a noi apparisce tale quale l’apprende la coscienza, quindi è che la regola rimota, o sia materiale, delle nostre operazioni, è la divina legge; la prossima e la formale è la coscienza» (5).
I termini «materiale» e «formale», che S. Alfonso aggiunge a quelli abituali di «remota» e «prossima», sono da intendere nel significato che ad essi dà il linguaggio scolastico. Senza la «promulgazione» nella coscienza («regola formale» del nostro agire) la stessa legge divina resta solo «regola materiale». Se la coscienza ha bisogno di attingere lealmente la verità dalla legge divina, questa diventa imperativa di fatto per la persona solo attraverso l’«apprendimento» della coscienza.
Si tratta di una reciprocità da non interrompere mai. Come sacerdoti, dobbiamo sostenere le coscienze nella loro maturazione e formazione in apertura leale alla verità. Dobbiamo però contemporaneamente impegnarci per annunziare la verità in maniera che possa essere riconosciuta come tale dalla coscienza. Credo sia segno di vera maturità morale il riuscire ad evitare qualsiasi radicalizzazione, in un senso o nell’altro, sviluppando in tutta la sua fecondità tale reciprocità. «Ninno nega, scrive ancora Alfonso, che siamo tenuti nell’operare a cercare e, trovatala, a seguire la verità. Ma domandiamo: in qual altro modo noi possiam conoscere questa verità, se non colla ragione? Bisogna dunque dire che quella verità noi dobbiam seguire che dalla ragione ci è rappresentata» (6).
Alle radici della libertà
Si tratta delle stesse prospettive che Dignitatis bumanae pone alla base della libertà religiosa. È opportuno rileggere le affermazioni fondamentali dei primi paragrafi: «Tutti gli esseri umani sono tenuti a cercare la verità, specialmente in ordine a Dio e alla sua Chiesa e sono tenuti ad aderire alla verità man mano che la conoscono e a renderle omaggio»; tali doveri però «attingono e vincolano la coscienza degli uomini», per cui «la verità non si impone che in virtù della stessa verità, la quale si diffonde nelle menti soavemente e insieme con vigore» (n. 1). Ne deriva che «gli imperativi della legge divina l’uomo li coglie e li riconosce attraverso la sua coscienza che egli è tenuto a seguire fedelmente in ogni sua attività, per arrivare a Dio suo fine ultimo» (n. 3).
Tutto questo costituisce una sfida per ogni pastore preoccupato per la salvezza del gregge. Occorre fare in modo che l’annunzio della verità sia tale da permetterle di essere riconosciuta come verità e di diffondersi nelle menti «soavemente e insieme con vigore». Non si tratta solo di rispettare le esigenze dei processi comunicativi, ma anche e prima di tutto di restare fedeli alla «condotta» del Cristo: alla sua chenosi misericordiosa.
Alla radice di queste affermazioni si trova la stima evangelica per la libertà, che, come sintetizza Gaudium et spes,,«è nell’uomo segno altissimo dell’immagine di Dio». E una stima sincera, ma senza ingenuità o superficialità, sapendo che essa oggi viene spesso cercata «in malo modo, quasi sia lecito tutto purché piaccia compresso il male» (n. 17).
Sono prospettive dense di conseguenze in tutto il cammino di formazione della coscienza. Vengono collocate da Alfonso alla base della proposta morale: «da Dio è stato considerato prima l’uomo in quanto libero; e poi è stata considerata la legge» (7). Ne deriva che è indispensabile il riconoscimento certo della legge da parte della coscienza perché si dia un’effettiva imperatività (8): «la legge incerta non può indurre un obbligo certo» .
Diventa allora possibile una risposta serena alla sfida della soggettività, cosi forte nel nostro contesto, che porta tante volte a forme di relativismo inconciliabili con il Vangelo. Non sarebbe una scelta pastorale saggia contrapporre alla soggettività del nostro tempo l’oggettivismo di alcuni momenti del passato. Dobbiamo fare in modo che la libertà possa essere approfondita e sperimentata da tutti come «segno altissimo dell’immagine di Dio».
L’accompagnamento e la legge della gradualità
Il ministero della formazione delle coscienze è accompagnamento paziente, franco, misericordioso. Occorre stare accanto alla persona perché non si fermi nel cammino del bene, ricordando l’orizzonte costituito dalla stessa perfezione misericordiosa del Padre celeste (cfr. Mt 5,48 e Lc 6,36) e stimolando al discernimento attento di tutti i passi effettivamente possibili.
È la legge della gradualità, secondo le indicazioni di Giovanni Paolo II nella Familiaris consortio. È utile richiamarle nella presentazione sintetica del n. 34. Innanzitutto il Papa sottolinea la grande importanza di una «retta concezione dell’ordine morale, dei suoi valori, delle sue norme». Esso infatti proponendo « il disegno di Dio creatore», non può essere «mortificante per l’uomo», ma « si pone al servizio della sua piena umanità, con l’amore delicato e vincolante con cui Dio stesso ispira, sostiene e guida ogni creatura verso la sua felicità».
Insieme a questa stima per la verità, la consapevolezza della storicità di ogni persona: «l’uomo chiamato a vivere responsabilmente il disegno sapiente e amoroso di Dio, è un essere storico, che si costruisce giorno per giorno, con le sue numerose libere scelte: per questo egli conosce, ama e compie il bene morale secondo tappe di crescita».
Per questo cammino di crescita sono essenziali « il desiderio sincero e operoso di conoscere sempre meglio i valori che la legge divina custodisce e promuove» e «la volontà retta e generosa di incarnarli nelle scelte». Perciò nessuno può «guardare alla legge solo come ad un puro ideale da raggiungere in futuro», ma deve «considerarla come un comando di Cristo Signore a superare le difficoltà» e a impegnarsi « sinceramente a porre le condizioni necessarie» per la sua osservanza.
Si tratta di prospettive essenziali alla proposta morale secondo S. Alfonso. Essere annunciatori della verità significa sempre anche essere ministri delle coscienze perché si aprano ad essa; essere ministri delle coscienze comporta sempre non solo il rendere comprensibile e sperimentabile la verità, ma anche lo stare accanto, con rispetto e sollecitudine, perché possano camminare in essa, in un crescendo di comprensione e di pratica attuazione.
La dinamica dell’amore
Tutto ciò è possibile, aggiunge ancora S. Alfonso, se nella proposta morale, come in tutta la predicazione, riusciamo a far sperimentare la dinamica di amore in cui siamo inseriti in Cristo, aprendo a una crescente conversione di amore. Di qui il suo forte richiamo, tuttora attuale: «Bisogna persuadersi che le conversioni fatte per lo solo timore de’ castighi divini son di poca durata… se non entra nel cuore il santo amore di Dio, difficilmente persevererà». Perciò « l’impegno principale del predicatore nella missione ha da esser questo, di lasciare in ogni predica che fa i suoi uditori infiammati del santo amore» (9).
Servire lealmente la verità‑amore non può che servire le coscienze perché si aprano, accolgano, attuino sempre più tale verità. È un ministero da compiere senza mai distogliere lo sguardo dal Cristo: è lui che, mediante lo Spirito, ci insegna a servire la verità servendo la coscienza di ogni uomo, soprattutto dei più piccoli, dei più deboli, dei più bisognosi di salvezza. Si radica qui la proposta di vita cristiana con la quale S. Alfonso è riuscito a creare, come scriveva don Giuseppe De Luca, «nei semplici, un cuore di santi e grandi santi»’°. È quanto il popolo di Dio continua ancora oggi a chiedere ai suoi sacerdoti. Potremo farlo se ci preoccuperemo di essere ascoltatori e servitori leali dello Spirito, la vera guida alla verità per ogni persona.
da Roma 1 febbraio 1996
P. Sabatino Majorano

_______
Note
(1) Il riferimento è a Dignitatis humanae, n. 1.
(2) Della vita ed istituto del Venerabile Servo di Dio Alfonso M.a Liguori; 1, Napoli 1798, p. 35‑39.
(3) Ivi, p. 39.
(4) Parte I, cap. IX, n. 31, in Opere complete, III, Torino 1847, p. 77.
(59 Istruzione e pratica pei confessori, cap. I, n. 4, in Opere complete, IX, Torino 1861, p. 7; cfr. S. MAJORANO, La coscienza. Per una lettura cristiana, Cinisello Balsamo 1994, p. 98‑105.
(6) Del1’uso moderato dell’opinione probabile, cap. II, n. 14: Monza 1831, p. 42‑43.
(7) Theologia moralis, lib. I, tract. I, cap. III, cor. II, n. 75, ed. Gaudé, I, Roma 1905, p. 50.
(8) Ivi, n. 79, p. 58.
(9) Foglietto in cui brevemente si tratta di cinque punti su de’ quali nelle missioni deve il predicatore avvertire il popolo di più cose necessarie al comun profitto, punto I, n. 1, in Opere complete, III, Torino 1847, p. 288.