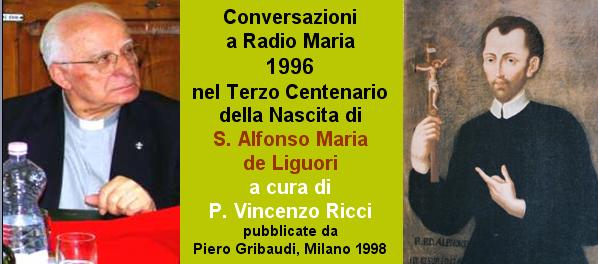
14. S. Alfonso musicista
S. Alfonso tra i musicisti [i titoletti sono redazionali]
Per introdurre la figura di S. Alfonso musicista, è necessario ricordare il ruolo che la musica ha sempre avuto nella spiritualità cristiana e nel cristianesimo. In tutti i secolila Chiesacattolica,la Chiesacristiana si è rivolta a Dio anche attraverso la musica.
Un altro Redentorista, P Paolo Saturno, in un’opera intitolata: Un musicista sconosciuto del 700 napoletano, faceva notare proprio questa straordinaria realtà, questo filone musicale che ha accompagnato tutta la liturgia del mondo orientale e del mondo occidentale, questo aspetto della sacralità della musica popolare, che ha inizio dall’Oriente e che annovera come primo cultore S. Efrem il Siro e unisce la musica orientale a quella occidentale che si rivela in S. Giovanni Bosco, l’ultimo esponente di quest’arte.
Tra i nomi che hanno lasciato indelebile immagine di sé, ricordiamo: Ilario di Poitiers, che mediò per l’Occidente l’espressione poetico‑musicale di S. Efrem; Ambrogio di Milano, Paolino di Nola, Venanzio Fortunato, Francesco d’Assisi con tutta la conseguente tradizione laudistica che arrivò fino al de Liguori; Filippo Neri che rappresentò la sutura, l’unione tra la tramontante lauda e il nascente oratorio, e perfino Martin Lutero, la cui pallida espressione del primitivo corale sfociò nelle colossali costruzioni di Bach nelle Cantate e nelle Passioni. Accanto a tutti questi cardini della spiritualità musicale cristiana, senz’ombra di dubbio, come sostiene lo stesso P. Saturno, merita di essere annoverato anche il santo musicista napoletano, soprattutto tenuto conto che ormai la sua espressione artistico‑musicale non è rimasta circoscritta al meridione agricolo d’Italia, ma grazie ai suoi missionari, è diventata popolare non solo in tutta Italia, ma anche in tutti gli altri Paesi della terra, dove i Redentoristi operano incessantemente da oltre un secolo e mezzo.
La musica di S. Alfonso
Tra i giudizi sull’opera di S. Alfonso e sulla sua azione, voglio citare, come primo critico che lo ha presentato, il maestro Del Piano. Questo professore scrisse un libro intitolato: Laudi spirituali nell’idioma toscano e napoletano per lo popolo, pubblicato a Napoli nel 1790. Se si pensa che S. Alfonso era morto tre anni prima, già si vede il successo che Alfonso riscuoteva non solo presso il popolo che cantava volentieri le sue canzoni e melodie, ma anche presso gli scrittori e i critici. Questo scrittore dice: «Molte, belle e divote canzoni sia in lingua toscana che in dialetto napoletano compose l’Ill.mo e Rev.mo Mons. Alfonso Maria de Liguori che fu Rettore Maggiore della Congregazione del SS. Redentore e vescovo di Sant’Agata de’ Goti, il quale, passato pochi anni sono all’altra vita, ha lasciato di sé la fama non solo di Santo, ma ancor di letterato. E come intendente di musica vi adattò semplici modulazioni e sì da per se stesso come per mezzo dei suoi congregati da per ogni dove insegnò al popolo di cantarle, onde tutta la città, massime in tempo di sera, sembrava un oratorio».
S. Alfonso, essendo stato buon musicista, inoltre viene ricordato in diverse enciclopedie. La prima, forse quella più interessante, fu pubblicata a Parigi nel 1896 ed è intitolata: Portraits et silhouettes de musiciens; poi compare nel Dizionario dei Musicisti pubblicato a Milano, nel 1937 e, ancora nel 1986, è stato stampato il Dizionario Enciclopedico universitario della musica e dei musicisti pubblicato a Torino. Ma, oltre all’interesse che gli studiosi hanno sempre dimostrato per S. Alfonso in quanto musicista, è importante ricordare che le sue canzoncine spirituali sono tuttora nel cuore del popolo italiano, specialmente nel Sud. La sua musica ha ispirato addirittura la colonna sonora di un film: L’albero degli zoccoli, di Ermanno Olmi, con Buon Natale, Buon Anno di Luigi Comencini dalle note di Tu scendi dalle stelle.
Come per le altre attività culturali di Alfonso come poeta, come pittore, la sua famiglia ebbe un ruolo fondamentale anche nel suo approccio alla musica. Il padre di S. Alfonso, don Giuseppe de Liguori, era molto appassionato di musica e naturalmente volle che pure il figlio vi si applicasse alla perfezione.
Il primo autore della vita di S. Alfonso, padre Antonio Tannoia, parlando della musica alfonsiana, dice che S. Alfonso «riuscì così eccellente nella Musica e nella Poesia, che anche da vecchio metteva in nota e componeva a meraviglia». Quindi è proprio tutta la vita di S. Alfonso che è stata permeata da questa passione, da questo amore per la musica fino agli ultimi giorni della sua esistenza terrena.
Naturalmente il padre, come per le altre facoltà si era interessato a procurargli maestri eccellenti, i migliori maestri del tempo, così fece anche per la musica, S. Alfonso frequentò infatti la scuola del celebre Gaetano Greco, la stessa scuola da cui uscirono Francesco Durante, Domenico Scarlatti, Nicola Antonio Porpora, Leonardo Vinci, Giovan Battista Pergolesi e altri.
Dal 1706 al 1723 S. Alfonso frequentò anche l’oratorio dei Gerolimini di Napoli, ove si coltivavano le tradizioni musicali volute da S. Filippo Neri. E fu proprio in questo luogo, in questo oratorio che il giovane musicista si esibì, come ricorda il Tannoia, nell’opera teatrale intitolata S. Alessio. Di Alfonso, che rappresentò la parte del demonio nel momento in cui suonava il cembalo, lo scrittore dice: «Lo toccò con tale maestria, che tutta l’udienza ne restò stupita». E dopo questa partecipazione a queste recite teatrali ufficiali, S. Alfonso prese spesso parte, dietro richiesta, alle feste delle famiglie vicine che per simpatia, ovvero per amicizia o per nobiltà lo invitavano per tenere vive e allegre le serate al suono del cembalo.
Per chi conosce S. Alfonso come un uomo molto serio, rigido e impegnato nello studio, quest’altro aspetto di giovialità che emerge del grande santo napoletano è piuttosto insolito. S. Alfonso, infatti, ha lavorato per tutta la vita in diversi campi, ha scritto tantissime opere, soprattutto grandi opere di morale, quindi di studio per la vita, di impegno per aiutare i sacerdoti nella loro missione di pastori delle anime: perché dunque questo suo particolare impegno anche alla musica, a scrivere canzoncine, a suonare il cembalo?
La finalità pastorale
Come per tutte le altre attività del Santo, specialmente quelle più piacevoli, quelle più umaniste, come la pittura e la poesia, S. Alfonso aveva sempre di mira una finalità pastorale: la guida delle anime.
Proprio in vista di dare una risposta al motivo per cui S. Alfonso si sia dato anche alla musica, lo scrittore Max Weber, dice: «Alfonso concentrò i propri obiettivi pastorali intorno alla missione. Soprattutto per le missioni, infatti, egli componeva le canzoncine spirituali che, per altro, cantava di persona, come testimoniano i suoi contemporanei». E il critico Salvatori, in uno studio su S. Alfonso, ha scritto: «Alle canzonette e agli idilli sdolcinati e spesso licenziosi del Maggi, del Rolli, del Metastasio e di cento altri sospiranti per fantastiche ninfe fuggiasche sempre tra i mirteti d’Arcadia, con semplicità ed efficacia e con fine più che letterario, altamente morale, Alfonso de Liguori contrapponeva le sue canzonette spirituali e sacre».
E da qui è facile ora la risposta circa le finalità e il successo delle composizioni musicali alfonsiane. Gli scopi più immediati da raggiungere per mezzo del canto erano la lode di Dio e della Vergine, l’annuncio della misericordia del Signore e dei misteri della fede ‑quindi c’era anche un insegnamento dottrinale nelle sue musiche ‑ e non ultimo sostituire nel cuore e nella mente dei fedeli canzoni lascive e spesso perniciose.
S. Alfonso, specialmente attraverso le indicazioni che ci ha lasciato il suo primo biografo, attraverso le sue testimonianze dice che ha parlato per le missioni, ha scritto per le missioni, ha dipinto per le missioni, che era la sua attività preponderante, era la finalità anche che aveva dato non solo a se stesso, ma anche all’Istituto. E soprattutto ricordando la vita del tempo di S. Alfonso e la grande presenza di canzoni poco morali, spesso addirittura canzoni volgari, lui ha dovuto preparare delle canzoni proprio per i giovani e per le giovani.
Ancora una volta ritorna quel pensiero, quell’interesse per le persone, per le categorie un po’ più deboli. E leggendo le poesie che poi lui musicò, ascoltando le sue canzoni non si può non ammirare il suo grande talento e la grazia dello Spirito Santo che in esse riluce. In tutte queste musiche, benché popolari, ci si trova diletto e compiacimento, e di conseguenza i giovani, i contadini le ascoltavano volentieri, le ricordavano per poi ricantarle.
In alcune canzoni S. Alfonso dimostra tutta l’arte che possedeva e lo spirito divino che lo inebriava. Ne è un esempio Servus timet, sulle parole di S. Bernardo, Selva romita e oscura, e poi Dove mi trovo, dove individua a meraviglia se stesso e gli affetti di un’anima che ama Dio con tutte le sue forze e anche con la gioia che questo amore suscita nella persona. Così ama Dio.
Canzoncine per il popolo
E per ogni tipo di predicazione S. Alfonso aveva preparato delle canzoncine: per l’adorazione al SS. Sacramento, perla Comunione, per l’atto di dolore, e quindi aggiunge _a quell’interesse morale che aveva avuto rivolgendosi al popolo, anche l’interesse di lode, di adorazione e di dottrina per tutti coloro che partecipano alle funzioni religiose guidate o da lui oppure dai suoi missionari.
Durante l’esposizione del SS. Sacramento, come riporta il Tannoia, «prima della predica cantar soleva la sua canzone: Gesù mio con dure funi, ma con tal divozione e con tono così flebile, che dava il popolo in dirottassimo pianto. Ed in senso di quei Padri fruttava più la canzoncina, che il sermone». E infatti, secondo S. Agostino, il canto è fatto bene se comporta lo stesso effetto di una preghiera; anzi di una duplice preghiera, quando è fatto bene porta altrettanti piaceri, altrettante conclusioni, qualche volta addirittura alla conversione.
Durante la predicazione i seguaci di S. Alfonso insegnavano al popolo le canzoni che il Maestro aveva creato, che aveva musicato. E il popolo poi le riportava sempre con fede non solo nelle chiese, ma addirittura nelle campagne, sui colli, nelle case. Il popolo si era talmente innamorato di questi canti che più di una volta gettò alle fiamme gli strumenti stessi con cui soleva accompagnare le canzoni profane. Ciò dimostra il carattere tutto popolare impresso dal nostro Santo alla sua musica.
S. Alfonso, come scrittore, come poeta, si è avvicinato al popolo, quindi le sue parole, i suoi libri, le sue poesie e le sue pitture parlano al cuore del popolo. Nella stessa maniera S. Alfonso parla al cuore del popolo attraverso le sue musiche, attraverso le sue canzoni. Poiché Alfonso canta per il popolo, canta ed esprime l’amore divino quasi con le stesse parole, gli stessi modi con cui il popolo canta gli amori umani, quindi per il popolo diventa facile cantare le canzoni di S. Alfonso perché sono canzoni dove le parole usate sono le parole che già la gente conosceva, che già la gente cantava.
E quindi era facile per la gente non solo imparare queste canzoni ma ripeterle volentieri durante il giorno.
Questo movimento di S. Alfonso verso il popolo costituì anche un importante fatto culturale perché interessò e incise sulla vita sociale, religiosa ed anche letteraria del popolo. S. Alfonso, con le sue opere, infatti è stato anche un’occasione di sviluppo culturale per il popolo perché è stato uno dei più grandi divulgatori della lingua italiana. In un certo senso, e con i limiti del paragone, lo possiamo confrontare a Martin Lutero che è diventato il padre della lingua tedesca.
Certo S. Alfonso non è il padre della lingua, però sicuramente ha saputo diffondere, far conoscere al popolo la lingua italiana utilizzandola nella predicazione, utilizzandola negli scritti e nei suoi canti. Egli voleva che tutti i suoi discepoli, i suoi seguaci, tutti i Redentoristi parlassero un linguaggio italiano, ma sempre comprensibile per il popolo.
E il popolo canta
Bisogna riconoscere che, se S. Alfonso ha amato il popolo, gli è andato incontro, il popolo a sua volta lo ha ricompensato seguendolo, amandolo, impegnandosi a fare propri i versi e le melodie alfonsiane.
Lo scrittore danese Jorgensen ricorda di aver sentito cantare, intorno al 1926, una melodia alfonsiana lungo la mulattiera che conduce a Poggio Bustone in provincia di Rieti. Scrive: « In testa al corteo ondeggia lo stendardo della Vergine, seguito dal gruppo di ragazze vestite di bianco. Poi viene un Crocifisso, scortato da un gruppo di uomini, e dietro c’è la musica, una rumorosa fanfara di dodici strumenti di rame; infine una larga coda di uomini e di donne ammassati senza ordine, un po’ a caso. Di tanto in tanto le ragazze, all’unisono, cantano un cantico monotono e infinito, in cui ritorna sempre lo stesso ritornello: Evviva Maria e chi la creò. L’hanno cantato tutta la mattinata, andando; continuano a cantarlo ora e continueranno fino alla tarda ora di sera, quando raggiungeranno Poggio Bustone».
E lo stesso scrittore ricorda con emozione di aver sentito addirittura a Betlemme la canzone Tu scendi dalle stelle.
Un altro critico e scrittore italiano, Palladino, narra addirittura di aver sentito fra i monti d’Abruzzo una delle tante canzoncine mariane di S. Alfonso: «Cadeva la notte d’un rigido febbraio e si stava in cima a una montagna che guardavala Maiella. Eral’ultimo giorno di una missione. La neve il suo bianchissimo manto aveva disteso sopra i monti e le vallate, sopra i tetti delle case… Le lampade sparse, poco a poco, si aggruppano, si addensano, riflettono un raggio rossastro sul niveo lenzuolo. Era tutto un popolo che si appressava alla casa dei missionari. E pel silenzio della notte, per quell’aria che agghiacciava, per quelle valli e quelle montagne irrigidite, corse il canto della speranza, della pace e dell’amore, corsero le alate strofette di sant’Alfonso: O bella mia speranza, / Dolce amor mio, Maria, / Tu sei la vita mia, / la pace mia sei tu».
Il Duetto
Vi è però un brano musicale di S. Alfonso che è senz’altro un capolavoro nel suo genere. «Abbiamo ‑ecco una testimonianza del tempo ‑ tra le sue canzoni un Duetto tra l’anima e Gesù appassionato, che dai musici fa cantare per intermezzo tra il catechismo e la predica, allorché in Napoli diede gli esercizi nella grande chiesa detta la Trinità de’ Pellegrini». Lo fece eseguire nel 1760 e sul frontespizio scrisse: Duetti tra l’Anima e Gesù Cristo. Con violino.
Bisogna dire che quest’opera, quella che fa di S. Alfonso uno dei grandi musicisti del suo tempo, ha avuto un’avventura un po’ straordinaria. S’era smarrita fino a quando fu ritrovata, circa un secolo dopo, nella Biblioteca Reale del British Museum di Londra. In Italia fu pubblicata per la prima volta nell’aprile del 1905 sul periodico Santa Cecilia, col testo in quattro lingue: francese, tedesco, inglese e, naturalmente, italiano.
Con questa opera S. Alfonso si pone al di sopra di tutti i maestri delle canzoncine spirituali, perché non si ferma a trattare soltanto un argomento, ma è una meditazione sulla Passione del Signore, una di quelle grandi meditazioni che trasportano l’anima ad incontrarsi con Dio.
da Roma 11 aprile 1996
P. Ezio Marcelli
Apri la pagina delle Canzoncine di S. Alfonso: testi, spartiti, esecuzioni
Video: S. Alfonso e la musica
(Da “Quanno nascette Ninno” – Musical, Pagani 2007)
[flashvideo file=video/SAlfonsoMusica.flv /]
Excellent line up. We’ll be linking to this excellent write-up on our web site. Sustain the great composing.